Nietzsche. E non chiamatelo nichilista...
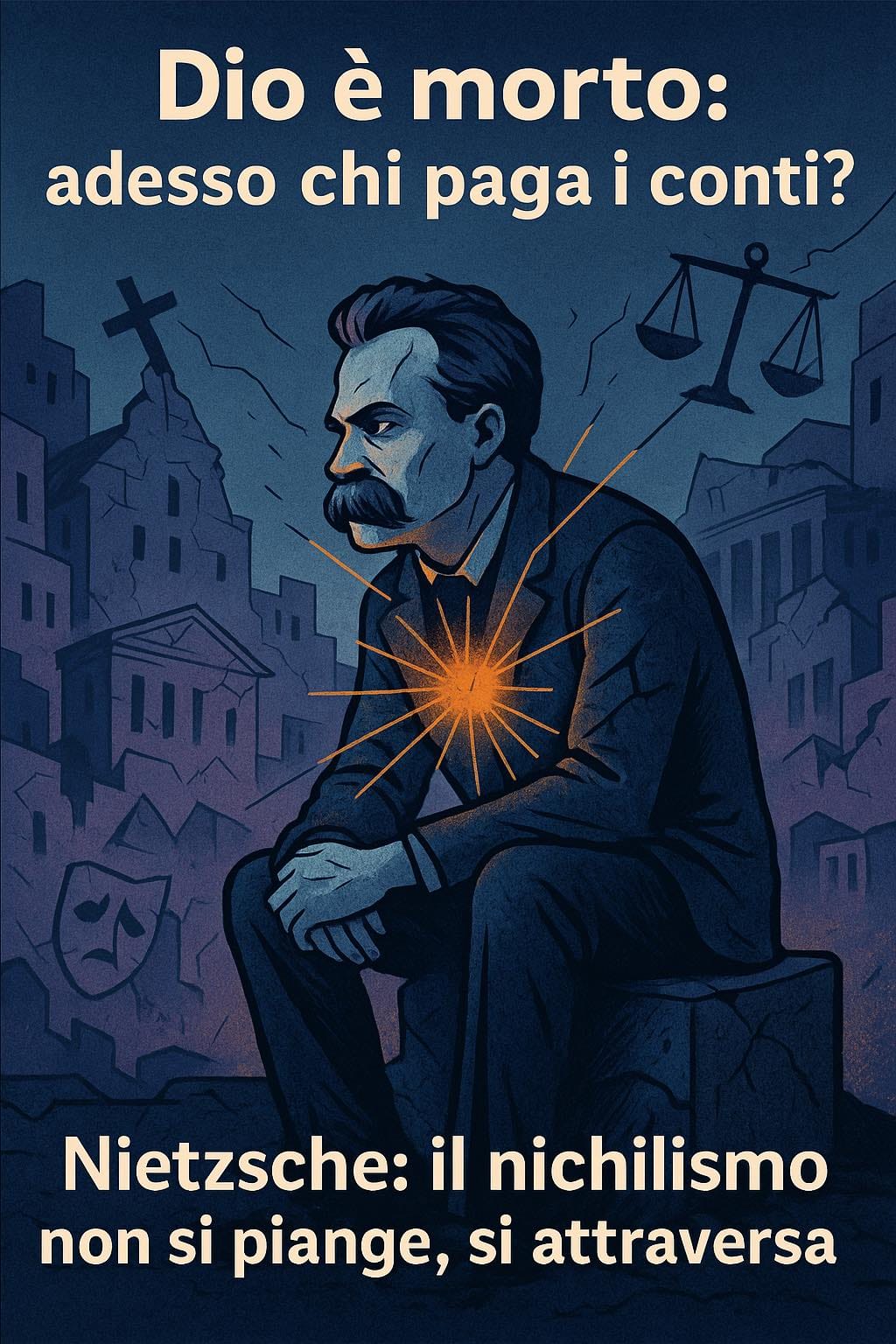
Chiamare Nietzsche «nichilista» è un modo elegante per dire che non lo si è letto fino in fondo. Il nichilismo è il suo problema, non la sua casa. È il nome della malattia che diagnostica nella civiltà europea: una lenta svalutazione di tutti i valori supremi, il momento in cui il mondo non regge più il peso delle giustificazioni che gli abbiamo cucito addosso. Il punto di partenza è semplice e crudele: una cultura che per secoli ha fondato il senso su un Altro mondo – Dio, il Bene in sé, il Vero, il Progresso – cosa diventa quando quel fondamento vacilla? Qui comincia la traiettoria del nichilismo.
Nietzsche chiama in causa, con una genealogia impietosa, la lunga alleanza tra Platone e il cristianesimo: l’invenzione di un mondo «vero» (quello delle idee, del Dio trascendente, della vita eterna) contro un mondo «apparente» (il corpo, il divenire, la storia). Il nichilismo non nasce dalla perdita di senso in astratto, ma dal logoramento interno di questa struttura: sono i nostri stessi ideali che si rivoltano contro di noi. Se «dire la verità» diventa il valore supremo, prima o poi la verità si rivolge anche contro Dio, contro la morale, contro le consolazioni metafisiche. La scienza, la critica storica, la filologia – tutta la serietà europea – scavano nelle fondamenta. Il risultato è la formula più famosa: «Dio è morto». Non è una bestemmia, è un referto.
Che cosa significa allora nichilismo? Per Nietzsche, anzitutto: la scoperta che «i valori supremi si svalutano», che non c’è più un perché ultimo in nome del quale soffrire, obbedire, sperare. La macchina che prometteva senso universale si ferma; gli ingranaggi continuano a girare ma non trainano più nulla. Ne derivano figure che Nietzsche mette in scena come tipi, non come eccezioni psicologiche: il credente stanco che continua a ripetere parole che non riesce più a credere, lo scienziato che dissolve ogni idolo ma non sa che farsene, il «buon europeo» che ha disimparato a volere. Il nichilismo è questo esaurimento della capacità di affermare, di dire sì: quando la vita continua biologicamente ma non sa più perché valga la pena essere vissuta.
Da qui la distinzione decisiva: nichilismo passivo e nichilismo attivo. Nel primo caso, la caduta dei valori trascendenti produce rassegnazione, anestesia, culto della sicurezza. Nietzsche lo tratteggia nell’immagine dell’«ultimo uomo»: piccolo, soddisfatto, incapace di grandi passioni come di grandi sofferenze, che strizza l’occhio e dice «abbiamo inventato la felicità». È il mondo della stanchezza storica, del «tutto è uguale», del livellamento. Il nichilismo, qui, è una sorta di inverno tiepido: nessuna tragedia aperta, solo la lenta evaporazione del tragico. Nel nichilismo attivo, invece, la stessa diagnosi – Dio è morto, i valori supremi sono crollati – diventa un pretesto per demolire più a fondo, per portare la critica al punto in cui può aprirsi uno spazio nuovo. È la lama che non si limita a constatare la ferita, ma taglia ancora per estirpare il tessuto malato.
Questo passaggio si comprende solo se si tiene ferma la parola-soglia che regge l’intera costruzione nietzscheana: volontà di potenza. Il nichilismo non è l’assenza di volontà; è volontà che ha perso oggetto, che non trova più figure in cui investire. La volontà di potenza è il nome del carattere interpretante, formante, selettivo della vita: il modo in cui ogni vivente valuta, pesa, ordina. Quando questa volontà è costretta da valori che la negano – la morale del risentimento, l’ideale ascetico, la colpa come debito infinito – si rivolge contro di sé, genera tipi umani che si nutrono di negazione, invidia, sospetto verso ogni forza che cresce. Il nichilismo è, in questo senso, volontà di potenza diventata auto-sabotaggio. La diagnosi genealogica della Genealogia della morale mostra proprio questo: come noi europei siamo diventati bravissimi a odiare la vita credendo di servirla.
Il gesto più radicale di Nietzsche è allora la proposta di una trasvalutazione dei valori. Non un semplice cambio di contenuti (buttare il cristianesimo per adorare qualcos’altro), ma un’inversione del criterio stesso: non più valori che giudicano la vita dall’esterno, ma valutazioni che nascono dalla vita in quanto tale, dalla sua capacità di sopportare, creare, trasformare. La trasvalutazione è la risposta possibile al nichilismo attivo: invece di sostituire un idolo con un altro, accettare che non c’è fondamento ultimo e assumere questo vuoto come condizione per creare. Qui il linguaggio si fa mitico: Zarathustra, l’eterno ritorno, l’oltreuomo. Figure estreme, spesso tradite dalle letture scolastiche: non supereroi, ma tipi che si misurano con il pensiero più duro, l’idea che ciò che scegliamo dovremmo volerlo non una volta, ma infinite. Il contrario dell’«ultimo uomo» che non vuole decidere nulla davvero.
Il nichilismo in Nietzsche non è quindi una tesi da difendere o da confutare; è un processo storico in cui siamo immersi. Non lo si abbandona per decreto morale né per nostalgia religiosa. Bisogna attraversarlo. Per questo il suo pensiero è così poco consolatorio: toglie la sedia da sotto ogni forma di quiete metafisica, ma non offre surrogati psicologici. In cambio, chiede una responsabilità inaudita: diventare noi stessi la misura dei valori che seguiamo, sapendo che non sono garantiti da nessun tribunale superiore. Chi cerca rassicurazioni troverà in Nietzsche solo una lunga radiografia del proprio bisogno di rassicurazioni.
Chiamarlo «filosofo del nichilismo» è dunque, a rigore, una scorciatoia: Nietzsche è il filosofo che prende sul serio il nichilismo occidentale e prova a spingerlo fino al punto in cui può trasformarsi in altra cosa. Nichilismo è il nome della soglia: dietro di essa non c’è il nulla, c’è la possibilità di una volontà che non si giustifica più con un aldilà, ma accetta di rispondere solo davanti alla terra, al tempo, agli altri viventi. Il problema non è che Dio sia morto, ma se esista ancora qualcuno che sappia reggere questa notizia senza crollare nella stanchezza o nella violenza. In questo senso, il nichilismo non è la fine del senso: è il rischio che bisogna attraversare per poter pronunciare ancora una volta, senza mentire, il verbo «volere».
— Eraclito di Rialto